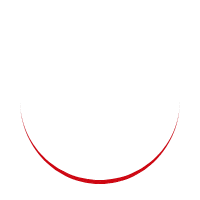Cosa sono gli antidolorifici, quali differenze è bene conoscere e come si usano correttamente in caso di reumatismo? Questo articolo fornisce un quadro generale e consigli utili.
Le malattie reumatiche sono quasi sempre associate a dolori, per cui si ricorre spesso agli antidolorifici. Ma quali medicamenti sono utili e appropriati per i vari tipi di dolori reumatici?
Come agiscono gli antidolorifici?
Gli antidolorifici (analgesici) modificano, riducono o eliminano i segnali del dolore. In tal modo sopprimono il sintomo, senza però combattere la causa che lo genera.
Gli antidolorifici sono indicati per il reumatismo?
>> In caso di malattie reumatiche infiammatorie, gli antidolorifici puri (privi di azione antinfiammatoria) vengono prescritti solo in aggiunta ai medicamenti antinfiammatori, per intensificare l’azione di questi ultimi.
>> Gli antidolorifici puri si utilizzano soprattutto per trattare i dolori da artrosi, o più in generale quando la componente infiammatoria svolge un ruolo secondario o non ci sono segni di infiammazione. Scopra di più alla fine di questo articolo.
Quali tipi di antidolorifici esistono?
È fondamentale la distinzione tra le due categorie di antidolorifici, oppioidi e non oppioidi. Oltre che suddivisi in queste due categorie, gli antidolorifici possono essere raggruppati secondo la scala a tre gradini dell’OMS. Entrambe le classificazioni sono indicative, ma aiutano a orientarsi nell’universo degli antidolorifici.
Oppioidi
«Oppioide» significa «simile all’oppio». L’oppio (dal greco opos = succo) è il lattice essiccato ricavato dalle capsule immature di papavero. Da esso si ricava la morfina, in passato denominata «morphium», un antidolorifico di origine vegetale omologato per il trattamento di dolori forti e molto forti. La morfina ha aperto la strada allo sviluppo di varie sostanze con effetti simili, che oggi costituiscono la maggior parte degli oppioidi.
La proprietà che accomuna tutti gli oppioidi è la capacità di legarsi ai recettori degli oppioidi presenti sulla superficie delle cellule nervose e di altre cellule in tutto il corpo. La maggior parte dei recettori degli oppioidi si trova nel cervello e nel midollo spinale, e una parte significativa anche nell’intestino. Quando gli oppioidi si legano ai recettori, attivano il sistema endogeno di modulazione del dolore, che nel midollo spinale inibisce la trasmissione dei segnali di pericolo e nel cervello sopprime la percezione del dolore. Alla riduzione del dolore si aggiungono altri effetti simili a quelli della morfina, quali la sedazione e l’euforia. Ciò significa che gli oppioidi calmano e inducono una sensazione di felicità intensa (euforia).
Secondo il linguaggio attuale, nella categoria degli oppioidi rientrano tutte le sostanze che agiscono tramite i recettori degli oppioidi. Quindi non solo gli oppioidi chimico-sintetici, ma anche quelli di origine vegetale ricavati dall’oppio, nonché l’oppioide endogeno endorfina, parola composta da «end» di «endogeno» (che significa prodotto internamente) e da «morfina», senza la m iniziale. Un forte rilascio di endorfine in situazioni di emergenza può far sì che persone con gravi lesioni non avvertano dolore nei primi istanti. Anche l’effetto euforizzante delle endorfine è simile a quello della morfina. Esistono dunque tre tipi di oppioidi:
Oppioide endogeno: endorfina
Oppioidi di origine vegetale:
morfina, codeina
Oppioidi sintetici: tramadolo, tilidina, fentanyl, ossicodone, buprenorfina, petidina, idromorfone ecc.
Gli oppioidi di origine vegetale sono detti anche oppiacei. L’oppiaceo codeina, tra l’altro, ha un potente effetto calmante della tosse e per questo è presente in alcuni sciroppi.
Antidolorifici non oppioidi
Gli antidolorifici che non si legano ai recettori degli oppioidi, bensì sfruttano altri meccanismi d’azione, sono detti non oppioidi. Alcuni agiscono presumibilmente sui recettori nel cervello, altri inibiscono la produzione di prostaglandine, sostanze messaggere proprie dell’organismo che rafforzano la trasmissione degli stimoli nell’ambito dei processi infiammatori.
Metamizolo
Il metamizolo, noto anche sotto il nome di novaminsulfone, è sicuramente l’antidolorifico non oppioide più forte. Questo medicamento soggetto a prescrizione medica è molto efficace, ma controverso, perché può causare come effetto collaterale raro una grave alterazione del quadro ematico (agranulocitosi).
Paracetamolo
I preparati a base di paracetamolo come Dafalgan®, Panadol®, Tylenol® o Zolben® sono molto diffusi. Hanno pochi effetti collaterali e sono per la maggior parte in vendita libera, ma non per questo privi di rischi. In caso di sovradosaggio, infatti, il paracetamolo può causare in breve tempo danni al fegato. Se si assumono in concomitanza medicamenti contro il raffreddore a base di paracetamolo come NeoCitran® o Pretuval®, si fa presto a superare la dose massima giornaliera di 4 grammi. Per precauzione è meglio non combinare mai antidolorifici e medicamenti antinfluenzali.
Capsaicina, cannabinoidi e altre sostanze vegetali
Tra gli antidolorifici non oppioidi si annoverano anche sostanze vegetali come la capsaicina derivata dal peperoncino, le sostanze vegetali secondarie neurotossiche dell’aconito napello e i cannabinoidi della canapa, tra cui in particolare il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), che riduce la percezione del dolore e rilassa i muscoli. I cannabinoidi agiscono legandosi a specifici recettori dei cannabinoidi del sistema endocannabinoide endogeno (cosa che presumibilmente anche il metamizolo è in grado di fare).
FANS
Diclofenac, ibuprofene e acido acetilsalicilico (Aspirina®) rientrano anch’essi tra gli antidolorifici, ma non sono medicamenti analgesici puri. Il loro effetto antidolorifico è infatti strettamente associato a un’azione antipiretica e antinfiammatoria. Per questo i medicamenti citati costituiscono una categoria a sé stante, quella degli antinfiammatori/antireumatici non steroidei (FANS).
La scala a tre gradini dell’OMS
Nel 1986 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha introdotto una scala a tre gradini per la terapia farmacologica del dolore associato a malattie oncologiche. Oggi la scala trova applicazione anche in ambiti diversi da quello oncologico ed è stata quindi estesa.
Secondo la scala a gradini, all’inizio di ogni terapia devono essere somministrate sostanze non oppioidi; se l’effetto è insufficiente si prosegue con oppioidi deboli (gradino 2). Nel caso in cui l’efficacia rimanga insufficiente, si può ricorrere a procedure minimamente invasive, che nell’ultimo gradino vengono integrate con oppioidi forti. È possibile combinare antidolorifici oppioidi, non oppioidi e analgesici adiuvanti (ovvero sostanze che possono influire sul dolore, ma non sono state sviluppate specificamente a questo scopo).

Quali antidolorifici causano dipendenza?
In linea di principio tutti gli oppioidi possono causare dipendenza, poiché modificano la chimica del cervello e in caso di assunzione costante creano rapidamente assuefazione: il corpo richiede queste sostanze sempre più spesso, finché non riesce più a farne a meno e deve assumerle in permanenza. In questo caso si parla di sviluppo della tolleranza: in pratica, per ottenere lo stesso effetto occorre una dose sempre maggiore.
La dipendenza è favorita dall’azione euforizzante degli oppioidi, che attivano il sistema di ricompensa del cervello. Anche la modalità di assunzione degli oppioidi influisce sul rischio di dipendenza: meno tempo impiegano le sostanze a entrare nel circolo sanguigno, più in fretta il cervello viene inondato da esse e quindi il rischio di dipendenza aumenta.
Ad esempio chi fa uso di oppioidi sperimenta un flash nel momento in cui la sostanza viene inalata o somministrata per via endovenosa. Le sostanze assunte sotto forma di compressa impiegano più tempo ad agire, da un lato perché lo strato di rivestimento esterno determina un rilascio graduale del contenuto, dall’altro perché la sostanza deve attraversare la barriera intestinale e quindi arriva più lentamente nel sangue.
In generale si raccomanda di assumere oppioidi per un periodo prolungato solo in casi eccezionali. Non bisogna inoltre sottovalutare gli effetti collaterali di queste sostanze, come stanchezza, nausea, vomito e stipsi. Per contro, gli antidolorifici non oppioidi – ad eccezione della cannabis ad alto contenuto di THC – non causano dipendenza o comportano solo un rischio minimo in tal senso e hanno meno effetti collaterali.
Quando bisogna usare gli antidolorifici e di quale tipo devono essere?
Se soffre di artrosi, molto probabilmente, per potersi muovere senza dolore, ha preso l’abitudine di ricorrere al paracetamolo prima di partecipare a un’escursione programmata o un corso di ginnastica settimanale. In linea di principio la Lega contro il reumatismo approva l’assunzione di un antidolorifico non oppioide a scopo preventivo. Un uso mirato può migliorare la funzionalità delle articolazioni permettendo di beneficiare degli effetti positivi del movimento. In tal caso va però tenuto presente che gli antidolorifici non aiutano a rendere più resistenti le articolazioni colpite. Questi medicamenti combattono solo i sintomi e inoltre non sono esenti da effetti collaterali.
Si raccomanda prudenza anche nell’assunzione di antidolorifici con azione antinfiammatoria (FANS). Possono essere utili e opportuni in presenza di disturbi provocati dal reumatismo delle parti molli, ma non sono più raccomandati per il mal di schiena.1 Se assume frequentemente antidolorifici non oppioidi, La invitiamo a consultare una/uno specialista della salute. Se frequenta un corso di ginnastica, Le consigliamo di informare la/il responsabile del corso sul fatto che assume antidolorifici e di chiedere se esistono alternative che possano esserle altrettanto d’aiuto.
In caso di reumatismo infiammatorio, il trattamento farmacologico mira a combattere l’infiammazione. Vengono prescritti antidolorifici puri solo se è necessario intensificare l’azione dei medicamenti antinfiammatori. In tale contesto si procede in base alla scala a tre gradini dell’OMS, utilizzando gli oppioidi per periodi prolungati solo in casi eccezionali.
L’essenziale in breve
- Gli oppioidi sono antidolorifici forti con un’azione rapida e un rischio elevato di dipendenza. Si raccomanda di farne un uso prolungato solo in casi eccezionali.
- In caso di artrosi o altre malattie reumatiche non infiammatorie, un preparato a base di paracetamolo senza obbligo di prescrizione (o un altro antidolorifico non oppioide) può consentirle di svolgere attività fisiche. Consulti una/uno specialista anche riguardo all’assunzione preventiva di antidolorifici a seconda della situazione.
- In caso di artrite reumatoide e altre malattie reumatiche infiammatorie, gli antidolorifici puri svolgono un ruolo secondario, in quanto possono solo potenziare la limitata azione di altri antinfiammatori.
Pubblicazione: 20 agosto 2025
Controllo specialistico: Alexandra Litzenburger, fisioterapista, M.Sc. Fisioterapia del dolore
Autore: Patrick Frei, Lega svizzera contro il reumatismo
Traduzione: weiss traductions genossenschaft
Note
- Corp N, Mansell G, Stynes S, Wynne-Jones G, Morsø L, Hill JC, van der Windt DA. Evidence-based treatment recommendations for neck and low back pain across Europe: A systematic review of guidelines. Eur J Pain. 2021 Feb;25(2):275-295. doi: 10.1002/ejp.1679. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33064878; PMCID: PMC7839780.